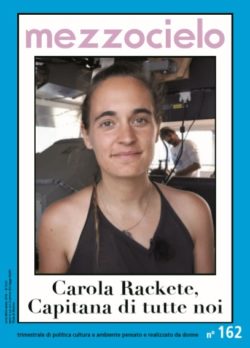Lima, il tucano e il suo becco
 Dell’altra Lima, quella dei quartieri residenziali, quella bella, moderna, della buona borghesia limegna di San Isidro, Miraflores, Barranco (dove risiede, ormai, certo, anche qualche studente della selva o degli altipiani), mi è rimasta invece un’impressione nata da una storia sui tucani che ho sentito lontano da lì, nel cuore della selva amazzonica, appunto.
Dell’altra Lima, quella dei quartieri residenziali, quella bella, moderna, della buona borghesia limegna di San Isidro, Miraflores, Barranco (dove risiede, ormai, certo, anche qualche studente della selva o degli altipiani), mi è rimasta invece un’impressione nata da una storia sui tucani che ho sentito lontano da lì, nel cuore della selva amazzonica, appunto.
Il tucano, nella stagione di secca, dalla cima degli alberi, riempie il cielo di richiami. È il suo modo di propiziare la pioggia, così che lui possa aprire il becco e bere direttamente dal cielo, l’acqua che cade. E questo perché, il tucano, non si azzarda a planare sulla superficie dei fiumi o delle lagune. Teme il suo riflesso, il becco osceno.
Ecco, la Lima residenziale mi è parsa un po’ come quel tucano lì. Asserragliata nei suoi palazzi splendidi, svettanti, o nelle sue villette immerse nel verde (dove spesso è con gli elettrodi ad alta tensione che si tengono a bada i ladri), vive la vita che più si avvicina a quella che ho visto nelle pubblicità televisive, in gran parte del Perù, chiedendomi chi mai si potesse permettere vite del genere. Una città nella città. O meglio, tante cittadelle dall’inconfondibile identità urbanistica (una per ogni quartiere) che sembrano specchiarsi solo in se stesse, nel proprio benessere, senza che possa davvero toccarle la vita della stragrande maggioranza dei peruviani che (solo per citare un dato significativo) contano ancora il 60% di analfabeti.
D’altro canto, basta solo imboccare la Carretera Panamericana diretti a Sud e farsi il tratto di costa desertica terrosa che da Lima porta a Nazca e poi ai 2.400 metri della ciudad blanca di Arequipa per rendersi conto degli standard di vita prevalenti: quadratini di terra-e-pietre recintati e basta; aggregati di casupole di fango e paglia, a volte, umbratili nel paesaggio lunare; una miriade di ricoveri seminati nel nulla, fatti anche solo di un telo nero o azzurro che s’agita al vento; una miriade di case appena edificate, qualche mattone, un recinto… di tanto in tanto, piccole oasi verdi di cimiteri. L’inferno dei terremotati del 2007, cui il governo ha «concesso» (qualcuno dice «venduto» a prezzi maggiorati) pezzetti di terreno ma non ha dato una lira per la ricostruzione… inferno che, appena fuori dalla bella Arequipa di pietra bianca (la seconda città più grande del Perù) si rinnova in segni meno drammatici ma non meno evidenti: terremoto del 2001. Stesso abbandono. E questo, in un paese e in una zona ad altissimo rischio sismico, dove cioè i terremoti dovrebbero essere gestiti, o addirittura messi in conto, come eventi ordinari.
Né hai minimamanete sentore della fatica degli altipiani infiniti, delle mandrie di lama e alpaca perse nel nulla, dei terrazzamenti scoscesi coltivati da braccia di donne, uomini, bambini, o arati da buoi smagriti, aggirandoti tra i centri commerciali, i viali, le scogliere sull’oceano, le sedi amministrative delle grosse compagnie dislocate nei quartieri della Lima bene. Né ti sorge il sospetto, guardando le architetture aerodinamiche dei palazzi più belli, che gran parte delle città peruviane siano un coacervo «horrible» o semplicemente anonimo di case eternamente in costruzione in una sorta di abusivismo e di abuso fatto sistema (Nazca, Puno, Iuliaca, Agua Calientes… o ancora i primi nuclei di «urbanizzazione» dell’isola di Tequile sul lago Titicaca, un grumo di cemento selvaggio innestato tra le più «urbane», per quanto infinitamente più povere, capanne in abobe). Il che suscita non poco sconcerto, soprattutto al pensiero di quali meraviglie architettoniche e ingegneristiche furono in grado di edificare gli Inca.
Così, quando un sabato sera, ti ritrovi nella bella piazza dell’Ovalo, nel cuore di Miraflores, tra ragazzi ultraglobalizzati, con tanto di skateboard e piercing, che protestano davanti al McDonald contro i «mangiatori di carne-assassini», esibendo la foto di una bellissima mucca Hereford, di quelle che non riescono a mettere piede forse nemmeno nei sogni della stragrandissima maggioranza dei peruviani, ti viene il sospetto che non è «la gestazione» di «un mondo migliore» quella cui stai assistendo, non ancora almeno, ma l’immagine di una parte di mondo che non ha nessuna intenzione o voglia o interesse (per timore, egoismo, ignoranza, noncuranza) di specchiarsi e scoprire quell’altro volto che gli restituirebbe un riflesso di sé troppo inquietante, troppo insostenibile, o semplicemente gravido di troppe responsabilità, preferendo piuttosto battaglie più globalmente condivise, più «urbane», meno limitrofe, e, tutto sommato, più consolanti, battaglie che mettono al riparo se stessi dall’immagine di sé, con tutto il corollario di brutture (e responsabilità) che «riflessi» del genere si portano dietro: becchi osceni… magari innestati al centro della propria faccia.
Per questo probabilmente non mi sono stupita quando ho letto che tra i limegni non ha poi suscitato così grande scandalo (anzi, un certo consenso piuttosto) quella «Ley de la Selva» (al momento solo sospesa) con cui il governo l’anno scorso ha tentato, appunto, di consegnare la foresta amazzonica alle compagnie petrolifere e all’abuso, legge, o meglio, decreti-legge che hanno invece determinato quella sollevazione durissima tra i nativi e quell’altrettanto dura repressione dell’esercito che la stampa meno distratta ha definito «massacri». Qualcuno ha persino parlato di un paese spaccato in due, addirittura. E d’altro canto, non c’è dubbio che, evocati dalla piazza dell’Ovalo – la selva così come la serra – sono davvero parte di un mondo di gran lunga più distante e indecifrabile di quel McDonald che hai davanti agli occhi, mentre ti aggiri nel cuore di quel Perù minoritario perfettamente integrato nel benessere esclusivo di una parte minoritaria di mondo, che, ti piaccia o meno, è anche il tuo.
(Lima, foto Gloria Li Brizzi)