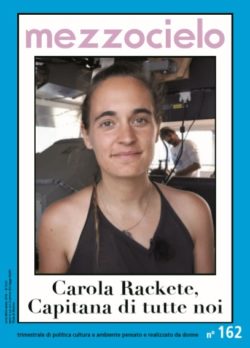Gente di qualità
Foto di Elina Brotherus, 2004
“Una bella vita è vedere il mondo in modo estetico”*
Il mio lavoro consiste nel camminare con la macchina fotografica nello zaino e il cavalletto sotto il braccio, nell’osservare i cambiamenti di luce, nel cercare un paesaggio semplice, nel descrivere una figura umana in uno spazio senza nessun intento narrativo. Contano il passare del tempo, il colore della luce, la forma del corpo, lo sguardo dell’artista.
L’immagine ha le sue regole. Si guarda un’immagine in modo diverso da come si guarda il mondo reale. …In tutto il mio lavoro la cosa che conta è lo sguardo dell’artista, che diventa percepibile nella fotografia. Mi pongo di fronte al paesaggio e la fotografia mostra quello che ho scelto di guardare. La schiena dell’artista-modella è serena, invita a osservare, senza disturbare. E’ come se l’artista guardasse la modella con uno sguardo neutrale, attento, condividendo lo stupore e l’ammirazione della visione. … Nelle mie immagini cerco quello che troppo spesso ci manca nella vita di tutti i giorni: calma, spazi ampi, sorpresa, vera solitudine e, come compensazione, un’esperienza condivisa. Elina Brotherus
Nel 1978 John Szarkowski aveva organizzato al Museum of Modern Art di New York una mostra dal titolo “Mirrors and Windows” che si proponeva di fare chiarezza critica sull’arte della fotografia così come si era sviluppata nel ventennio precedente negli Stati Uniti. La tesi di Szarkowski, in sintesi, era che esisteva, nella fotografia a lui contemporanea, una dicotomia tra chi utilizzava la fotografia come uno specchio (mirror), come mezzo di espressione di sé e chi pensava la fotografia come strumento di esplorazione del mondo, come finestra (window) di osservazione. L’importante mostra americana e le suggestive riflessioni di Szarkowski, che tanto hanno influenzato la cultura critica internazionale, dopo quasi un quarto di secolo, conservano intatte la loro lucida e radicale forza analitica. Tuttavia il critico americano, pur presentando opere di Judy Dater, Sheila Meztner o di Sylvia Plachy, non si era preoccupato di quella fertilissima area creativa femminile che proprio negli Anni Settanta si era messa in luce con una vasta e diversificata produzione orientata quasi univocamente nella direzione dell’autoriflessione. Lo “specchio” delle artiste, soprattutto americane, era diventato appunto uno strumento di indagine di sé, del proprio ruolo, di una condizione personale, sociale o psicologica che, per ampiezza e pluralità di risultati, non aveva precedenti nella storia dell’arte.
E’ forse in queste esperienze femminili che si possono trovare le radici del lavoro di Elina Brotherus. Non tanto nella formulazione estetica quanto nei presupposti di libertà analitica e creativa che erano in un certo senso il vessillo innovativo delle artiste di allora. Le sue immagini, infatti, raccontano una storia semplice e universale: quella di una giovane donna che incontra nella sua vita di ogni giorno piccoli e grandi eventi, piccoli e grandi dolori, piccole e grandi gioie. Lo fa in modo diretto, frontale, quasi classico, senza artifici tecnici, senza costruzioni o ricostruzioni. Usa la macchina di grande formato come uno specchio che riflette con onestà quello che vede ma anche come fosse uno specchio magico, che altera il tempo della riflessione e consente la meditazione e la sublimazione. Lei stessa è il centro dell’indagine creativa e la sua opera gioca sul doppio registro dell’io narratore e dell’io narrato. Tuttavia, rispetto alla tradizione contemporanea che lavora sulla riflessione di sé, sull’autoritratto, la sua opera si colloca in modo eccentrico. Lontana, almeno agli inizi della sua carriera, dalle tensioni delle metropoli occidentali ed immersa invece nelle alte luminosità nordiche, in una dimensione di spazi e silenzi che invitano all’introspezione, Elina Brotherus riscopre una poetica autonoma da ogni tendenza. Rifiuta, al contrario di Cindy Sherman, la messa in scena di tipologie e stereotipi a favore di una narrazione semplice e diretta. Teme, a differenza di Nan Goldin, la cronaca puntuale degli eventi della sua vita e sceglie invece la strada della metafora, della citazione, del suggerimento. Elina Brotherus dichiara di poter fotografare solo quando le accade qualcosa che rende le sue immagini autentiche, emozionalmente genuine e questo la fa sentire vicina alla tradizione documentaria: i suoi autoritratti ricostruiscono situazioni reali, traducono sentimenti realmente vissuti ma riescono a superare l’episodio soggettivo per diventare generali, collettivi e condivisi.
Il corpo della sua opera, come lei stessa lo ha organizzato nel volume “Decisive Days. Photographs 1997-2001” (Pohjoinen, Oula, Finland 2002), traccia una sorta di autobiografia precoce (Elina è nata a Helsinki nel 1972) che è al contempo anche la storia della sua evoluzione creativa. Scandita in quattro capitoli, la narrazione inizia con la serie “Das Mädchen Sprach von Liebe” (la ragazza parla d’amore, 1997-1999) nella quale raccoglie immagini che raccontano la morte dei genitori, il suo matrimonio, le percosse, il dolore, la separazione, la solitudine. Sono immagini dirette e frontali, interpretate con un rigore che nulla concede alla compassione o al compiacimento. Compaiono i primi paesaggi, affrontati con analoga lucidità documentaria che si stempera in una sorta di stupore cromatico nella serie “Suite française 1” (1999), realizzata durante il suo primo soggiorno in Francia. In questa serie il suo vissuto rimane quasi sullo sfondo, a favore di un’incuriosita indagine sui colori della notte, sui paesaggi e le città francesi. Nella “Suite française 2” affronta il problema dell’estraneità. Lavora sul microcosmo nel quale vive, sulla sua solitudine, sull’incomprensione della lingua, sui problemi legati all’impossibilità di comunicare. Come una bimba in un giardino d’infanzia inizia a etichettare gli oggetti attorno a lei con piccoli Post-it gialli, definisce le cose, gli ambienti, gli stati d’animo. Cerca, attraverso il linguaggio, di costruirsi una base di certezze, di entrare in relazione con una nuova e diversa realtà, di appropriarsi dell’ambiente nel quale ora vive. La sua è sempre una narrazione autobiografica ma la diversa condizione esistenziale la porta ad assumere un atteggiamento nel quale a volte l’osservazione sfuma nel sorriso: i suoi autoritratti sono come sempre autentici, diretti e sinceri, ma si avvicinano e toccano realtà meno soggettive e sempre più universali. Per l’ultima serie, ancora in corso, sceglie un titolo inglese “The New painting”, che le è suggerito da un’amica gallerista: “La fotografia è la nuova pittura”, afferma provocatoriamente Edda Jonsdottir, ed Elina raccoglie la provocazione. Ha raggiunto una grande maturità narrativa e affronta senza timori il confronto con i temi e le suggestioni della pittura classica. I paesaggi diventano numerosi, conservano l’algido rigore documentario, sfruttano gli orizzonti per raggiungere un ideale di semplificazione che sfiora l’astrazione. La figura umana diventa misura dello spazio, gioca con la luce, si concede ammiccanti riferimenti a temi classici.
Il suo è un itinerario in continuo divenire, un esempio luminoso e sincero di una creatività che non teme di analizzare se stessa ma che non rifiuta, ormai, il confronto con la cosmogonia della narrazione per immagini. Nel corso degli ultimi anni la sua notorietà internazionale è aumentata esponenzialmente, in concomitanza con le numerose mostre a lei dedicate. E tuttavia Elina sembra passare indenne attraverso le trappole dei riconoscimenti ufficiali. Padrona del proprio linguaggio e a lui fedele come pochi altri artisti contemporanei, sembra ignorare i flussi e le tendenze delle mode e continua a lavorare sul proprio vissuto trasformandolo, con luminosa, malinconica leggerezza, in una metafora universale.
Giovanna Calvenzi