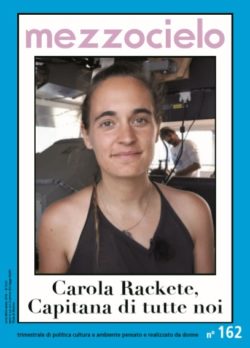i lati oscuri di un suicidio in carcere
Nonostante la condanna della Corte Europea per i Diritti Umani di Strasburgo intervenuta, nei mesi scorsi, a rammentarci il trattamento inumano e degradante riservato ai detenuti delle carceri italiane, nel nostro Paese di galera si continua a morire. Proprio in questi giorni, un nuovo suicidio avvenuto all’interno della casa circondariale “Malaspina” di Caltanissetta ha riportato l’attenzione sulle condizioni e lo stato d’animo dei detenuti, soprattutto quando ai problemi del carcere si sommano quelli dell’immigrazione.

 Mouhamed Ahmed Mokhar aveva 24 anni e un destino da egiziano scampato ai conflitti sanguinosi tra l’esercito e i gruppi islamisti. Accusato di essere uno degli scafisti della traversata dell’8 agosto (110 migranti a bordo dell’ennesima carretta del mare e due pakistani morti), Mouhamed non ha retto. Dopo aver realizzato un cappio con i lacci delle scarpe, l’uomo si è impiccato in cella e a nulla sono valsi i soccorsi degli agenti in servizio e dei medici. Mouhamed, in carcere dal 16 agosto, è morto in ospedale, dopo innumerevoli tentativi di rianimazione.
Mouhamed Ahmed Mokhar aveva 24 anni e un destino da egiziano scampato ai conflitti sanguinosi tra l’esercito e i gruppi islamisti. Accusato di essere uno degli scafisti della traversata dell’8 agosto (110 migranti a bordo dell’ennesima carretta del mare e due pakistani morti), Mouhamed non ha retto. Dopo aver realizzato un cappio con i lacci delle scarpe, l’uomo si è impiccato in cella e a nulla sono valsi i soccorsi degli agenti in servizio e dei medici. Mouhamed, in carcere dal 16 agosto, è morto in ospedale, dopo innumerevoli tentativi di rianimazione.
Certo, il suicidio rimane un fatto individuale e Mohamed non è piovuto al Malaspina dal cielo, ma da un contesto che si evolve dall’arrivo a Pozzallo fino all’accusa di essere uno scafista.
Le drammatiche condizioni delle carceri, troppo spesso denunziate dalle associazioni preposte e dai deputati in visita, e il disagio non da meno, legato all’essere un migrante detenuto in un paese straniero, stimolano però una riflessione sulla necessità di intervenire per affrontare quella che può essere definita una marginalità nella marginalità. Mohamed disponeva di un servizio di mediazione culturale, con interprete, adeguato? Ha potuto usufruire di un colloquio con uno psicologo? Sono questi i “dettagli” ancora da chiarire.