erotica e impertinente la Venere in pelliccia di Polanski
Arte, letteratura, teatro e cinema si mescolano, compenetrandosi nell’ultima opera di Roman Polanski, Venere in pelliccia. È il trionfo del ‘meta’, in cui, nel pieno rispetto delle unità aristoteliche di tempo, luogo e azione, la finzione cinematografica fa da cornice a un’opera che assomiglia a una di quelle scatole cinesi o ad una matrioska della storia nella storia.
 Dalla Venere allo Specchio di Tiziano, alle Baccanti, dal romanzo erotico di Sacher-Masoch del 1870, a un teatro parigino che mette in scena la pièce, al film stesso. Si annullano i confini tra narratore e narrato, registi e attori, personaggi e persone, dominante e dominato, schiavo e padrone. È il gioco dei ruoli per eccellenza, l’interpretazione nell’interpretazione ritualizzata, che confonde con la sua ambiguità ed esalta. Una storia circolare e speculare, in cui lo specchio, quello stesso specchio della Venere, seppur assente, diventa elemento cardine, emblema, di un gioco di proiezioni e riflessioni, e rimandi artistico-letterari, in una intertestualità esibita, persino negli elementi scenografici dimessi e dal valore simbolico-evocativo, traccia d’altro, referenziali. La finzione diventa più reale di un reale che è sfumato, come assorbito dalla scena nella scena. E c’è una sincerità sconcertante e molesta che ostenta l’artificio, senza provare a celarlo, rompendo ogni forma di patto implicito con lo spettatore, faccia a faccia, adesso, con la sua natura animale, nudo e senza via di scampo. Scarnifica le pulsioni umane, Polanski, ‘schiaffeggiandole’, penetrandovi con una carrellata voyeuristica che sbircia nell’intimità ovattata e claustrofobica, ma mai asfissiante, di un teatro vuoto, campo di battaglia della guerra tra sessi. Ma, oltre la ribalta, oltre lo schermo, noi cinefili distratti, con le teste all’insù, ne siamo il pubblico sedotto: è la recita su un palcoscenico, nella sua plastica staticità che un dialogo serrato e intenso dinamizza, tra battute scritte per essere improvvisate e improvvisazione ad arte.
Dalla Venere allo Specchio di Tiziano, alle Baccanti, dal romanzo erotico di Sacher-Masoch del 1870, a un teatro parigino che mette in scena la pièce, al film stesso. Si annullano i confini tra narratore e narrato, registi e attori, personaggi e persone, dominante e dominato, schiavo e padrone. È il gioco dei ruoli per eccellenza, l’interpretazione nell’interpretazione ritualizzata, che confonde con la sua ambiguità ed esalta. Una storia circolare e speculare, in cui lo specchio, quello stesso specchio della Venere, seppur assente, diventa elemento cardine, emblema, di un gioco di proiezioni e riflessioni, e rimandi artistico-letterari, in una intertestualità esibita, persino negli elementi scenografici dimessi e dal valore simbolico-evocativo, traccia d’altro, referenziali. La finzione diventa più reale di un reale che è sfumato, come assorbito dalla scena nella scena. E c’è una sincerità sconcertante e molesta che ostenta l’artificio, senza provare a celarlo, rompendo ogni forma di patto implicito con lo spettatore, faccia a faccia, adesso, con la sua natura animale, nudo e senza via di scampo. Scarnifica le pulsioni umane, Polanski, ‘schiaffeggiandole’, penetrandovi con una carrellata voyeuristica che sbircia nell’intimità ovattata e claustrofobica, ma mai asfissiante, di un teatro vuoto, campo di battaglia della guerra tra sessi. Ma, oltre la ribalta, oltre lo schermo, noi cinefili distratti, con le teste all’insù, ne siamo il pubblico sedotto: è la recita su un palcoscenico, nella sua plastica staticità che un dialogo serrato e intenso dinamizza, tra battute scritte per essere improvvisate e improvvisazione ad arte.
Un duello dialogato che, in un climax ascendente, trova il suo acme nell’ossessione pura, germe di follia dionisiaca, dei tonanti versi euripidei che segnano il compiersi di una metamorfosi. Tratta dall’omonimo testo teatrale del drammaturgo David Ives, a sua volta ispirato al classico ottocentesco, bibbia del sadomasochismo, la pellicola è una pièce a due voci, quella di un regista, alter ego dello stesso Polanski, Mathieu Amalric, che cerca la sua Wanda per l’adattamento teatrale del testo di von Masoch, e di un’attrice scarmigliata e impetuosa, Emmanuelle Seigner, nel suo processo di personificazione con la protagonista da interpretare che si fa identificazione totale, perversione sublime. Wanda, in realtà atavicamente incarnata da entrambi, in quanto entità ‘ambivalenti’, è pura voluttà erotica e impertinente, eros masochistico, vero protagonista, sebbene solo simulato e mai triviale, nell’eleganza raffinata del tocco autoriale.
Sullo sfondo, il tema dell’omosessualità repressa e tematiche misogine e sessiste, ma è una donna-demiurgo, Vanda/ Venere in carne e ossa e pelliccia e stivali, a tenere le fila del gioco delle parti, a ‘dominare’ e plasmare la scena, catalizzandone l’attenzione, in una feroce danza baccanale al cospetto dell’uomo inerme, come a voler ribadire la ridicola ironia misogina dell’epigrafe iniziale: «E l’Onnipotente lo colpì, e lo consegnò nelle mani di una donna».



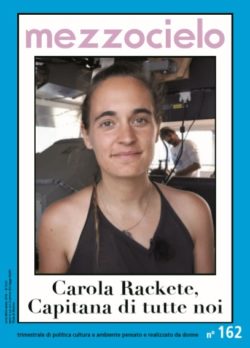




Bello il film e l’articolo che gli rende merito, anche se forse omette il tocco di naturalezza contemporanea che rende tutto
plausibile.
Finalmente una recensione degna di questo nome!
Forse l’ultima parte doveva essere più sviluppata, ma mi rendo conto che forse sarebbe diventato un trattato