Un’immaginaria linea di confine nel sapere
E’ un dato di fatto, la ricerca avanza all’estero ma gli scienziati e i medici che la portano avanti, nella maggioranza dei casi, sono italiani. La domanda che viene naturale porsi è: “Perché?”, la risposta più semplice sembrerebbe essere che in Italia non ci sono i finanziamenti, non ci sono gli strumenti, le strutture, che i ragazzi non vengono valorizzati, ma se menti eccelse riescono ad uscire dalle Università italiane un motivo ci sarà, qualcosa di buono questo Stato dovrà pur averla, dovrà pur averlo fatto, li avrà cresciuti, educati in modo tale che i loro talenti si sarebbero potuti sviluppare in qualche modo. La didattica italiana è una di quelle che prepara al meglio i suoi allievi, insegna loro discipline che in altri Stati vengono messe da parte per un bel po’ (un esempio ne è il greco, studiato in Italia dai ragazzi fin dai 14 anni di età), un altro riguarda gli studenti di medicina, anche se su questo, forse, ci sarebbe qualcosa da ridire, infatti, i nostri futuri Dottori imparano tantissimo teoricamente ma praticamente non “toccano” paziente, nemmeno indirettamente, se non fino a dopo la Laurea, portando quindi i ragazzi a sapere tutte le malattie rare di questo mondo ma a trovarsi Dottori al primo caso indecisi tra una tonsillite batterica ed una mononucleosi. Questo non accade in altri Paesi dove pure gli studenti Erasmus vengono portati in sala operatoria e viene loro chiesto, in una terza lingua, l’esempio potrebbero essere uno studente italiano, un medico ungherese che parleranno l’inglese per comprendersi, di passare i ferri del mestiere al chirurgo, di stare fianco a fianco al professionista e non solo per guardare, toccando con mano quella che sarà la loro vita futura. Molti universitari, tornando dalla loro esperienza all’estero si dicono soddisfatti di quello che hanno vissuto, ammettono di non aver imparato molto teoricamente ma di aver imparato molto praticamente, dicono di aver trovato una differenza abissale tra i tirocini obbligatori in Italia e quelli di poche settimane che hanno frequentato nel loro periodo di studi fuori dai confini natii. Dove sta la verità, dunque? Qual è la formazione migliore? Quella che insegna tanto praticamente e poco teoricamente od il contrario? Qual è la giusta via da seguire se i nostri ragazzi a 25 anni si accorgono della differenza e vorrebbero poco studiare e molto sperimentare ma a 40 anni saranno dei bravissimi professionisti perché con un bagaglio culturale e teorico ben saldo o quella dei ragazzi stranieri, molto bravi praticamente, molto versione reale dell’Allegro chirurgo ma poco preparati teoricamente che a 40 sapranno le stesse cose che sanno adesso? Forse, sarebbe meglio usare idee “antiche” per fatti nuovi, ossia sarebbe meglio promulgare la virtù del giusto mezzo, forse la verità non sta né dentro né fuori l’Italia, ma in un’immaginaria linea di confine.



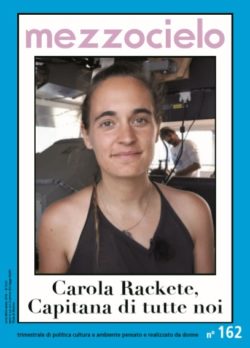




Non so bene come funzionino le cose all’estero, ma credo che, in genere, si tenda ad essere più orientati verso una preparazione prettamente specifica e specializzata, limitando di fatto l’orizzonte culturale di ogni studente. Paesi come gli Stati Uniti privilegiano una formazione tecnica ad una umanistica; vengono create strutture specializzate e ben fornite dove una determinata scienza viene smembrata nelle sue parti atomiche e diversi gruppi di ricerca si focalizzano su una singola componente a scapito di una visione d’insieme della cosa. L’uomo viene sempre inquadrato in funzione di qualcosa, affinchè s’impadronisca di una tecnica per impastare un mattone che contribuirà a plasmare una struttura ben più vasta da cui è separato; ma non viene mai inteso come un soggetto capace di contenere in sè una molteplicità di saperi diversi, finalizzati non alla produzione, ma alla coltivazione del proprio sè. Tecnica contro Umanità, utilità contro speculazione. Il problema è un gioco tra questi due opposti che si respingono, ma che possono anche conciliarsi fra loro: teoria e pratica sono due facce della stessa medaglia, senza la pratica la teoria è vuota e viceversa; è un problema di mentalità, un pregiudizio nello sguardo di chi osserva, giudicando l’una superiore all’altra. Un simile modo di ragionare denota l’incapacità di una visione d’insieme, il non saper cogliere quell’unità di cui la realtà esterna è solo parte. Confondendo così la parte col tutto, l’uomo si svaluta in favore della tecnica e svaluta la tecnica in favore dell’uomo. La pratica è paragonabile al linguaggio nel quale una persona si esprime: più è colta, più consapevolezza di sè e del mondo acquisisce, più articolati saranno i suoi discorsi e più raffinata la loro espressione; il fulcro di ogni cosa è il soggetto che, prima di applicarsi alla tecnica, dev’essere coltivato come essere umano. Il problema, a mio avviso, è il modo in cui viene presentata l’istruzione scolastica: nei licei lo studio viene visto come un processo meccanico, un dovere da adempiere per non avere attriti in famiglia. Discipline come matematica e fisica raramente vengono percepite nella loro vera essenza: ci si sofferma solamente a risolvere l’equazione, focalizzandosi sul come e non sul perchè; si spostano i numeri da un membro all’altro cambiandoli di segno, ma in pochi sanno che si sta utilizzando il principio di equivalenza delle equazioni; si fa così perchè si fa così, e proprio questo fatto denota una certa mancanza di curiosità che è il sale dell’esistenza umana: senza essa non c’è scienza, non esiste consapevolezza, e l’uomo vivrà la sua vita seguendo semplicemente una lista di cose da fare, senza porsi domande che esulino da questo meccanico tecnicismo. La scuola dovrebbe cambiare, mostrare l’anima di una disciplina, intrattenere gli studenti facendoli appassionare non solo alla materia, ma alla conoscenza in generale. La sapienza è il fine di ogni istruzione, ed è compito dell’insegnante puntare il dito verso questo orizzonte e non semplicemente sugli esercizi da svolgere, pena il due nel registro. Se la società mirasse a stimolare in noi la vera umanità, la distanza fra cultura e tecnica s’annullerebbe di colpo. Se esiste questo spazio vuoto, questo ostacolo che divide parti diverse della stessa natura umana, è perchè siamo noi ad erigere queste barriere tramite un errata percezione che abbiamo di noi stessi e del mondo; un’idea errata capace di causare interferenze nella spontanea connessione che si concretizza nel gioco di specchi interno-esterno.