pace, conflitti, accoglienza, dove si e dove no
La bella notizia del conferimento del premio Nobel per la pace a quattro attivisti tunisini, protagonisti della “rivoluzione dei gelsomini”, è stata sovrastata e quasi cancellata da quella, orribile, della strage di Ankara.
 Il contrasto così violento tra i due avvenimenti, da una parte il riconoscimento alla società civile di un paese oggi democratico, con una costituzione improntata alla libertà di coscienza e alla parità tra uomini e donne, e minacciato dal terrorismo, e dall’altra il tentativo di soffocare la voce di migliaia di persone che, in un altro paese di religione islamica, manifestavano per la pace e la democrazia, rende esplicito un nodo geopolitico e culturale attualmente cruciale. Si tratta del duello mortale tra l’islam fondamentalista e l’islam contemporaneo, aperto alla democrazia, al pluralismo e agli apporti di culture diverse.
Il contrasto così violento tra i due avvenimenti, da una parte il riconoscimento alla società civile di un paese oggi democratico, con una costituzione improntata alla libertà di coscienza e alla parità tra uomini e donne, e minacciato dal terrorismo, e dall’altra il tentativo di soffocare la voce di migliaia di persone che, in un altro paese di religione islamica, manifestavano per la pace e la democrazia, rende esplicito un nodo geopolitico e culturale attualmente cruciale. Si tratta del duello mortale tra l’islam fondamentalista e l’islam contemporaneo, aperto alla democrazia, al pluralismo e agli apporti di culture diverse.
In questa lotta feroce si inseriscono potenze e poteri con interessi diversi e diverse responsabilità: l’Europa, tra le altre, ha quella, ineludibile, dell’accoglienza dei milioni di profughi che questo conflitto, presente in varie forme in diversi paesi, continua a produrre. Responsabilità ineludibile, eppure abbiamo visto in Europa sorgere muri non metaforici, rimpallare compiti, centellinare risorse; in Italia, un diluvio di parole d’odio fa da contraltare al prodigarsi concreto di servizi sociali e sanitari e di tanti volontari.
Forse sono queste parole, compagne di una islamofobia crescente, a frenare con la paura il diffondersi della più semplice e diretta forma di accoglienza: aprire ad un profugo la porta di casa propria. Il soggiorno in famiglia è possibile per i migranti che hanno ottenuto lo status di rifugiati, ma le esperienze in Italia per ora sono poche. Ciò che molte famiglie fanno per i minori disagiati non sembra facile da fare per i rifugiati.
In una piccola isola dell’estremo nord d’Europa, invece, la pensano diversamente: in Islanda 17.000 persone hanno dichiarato di essere disponibili ad accogliere profughi o ad aiutarli direttamente in vari modi e 240 famiglie si stanno già attivando per ospitarli. Non sembrano grandi cifre, se non considerando che gli islandesi sono 322.000 e che si tratta di un popolo etnicamente e culturalmente compatto, che non ha mai conosciuto il “melting pot” e le convergenze e convivenze culturali di paesi come l’Italia.
Sembra quindi che gli islandesi, così all’avanguardia per la tutela dei diritti civili e delle diversità, eppure tanto legati alla tradizione da non usare tuttora i cognomi e deviare i tracciati delle nuove strade per non disturbare i troll, abbiano qualcosa da insegnarci: la semplice arte dell’accoglienza e il realismo magico della solidarietà.



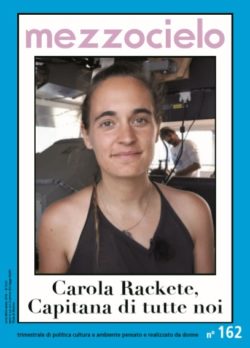




Purtroppo la paura e i muri servono a troppi; servono ai politici per catturare facili consensi parlando agli istinti primordiali, servono a chi lucra sulle strutture di accoglienza; servono a chi fa traffico di uomini (protetti dagli stessi signori della guerra che comprano le armi prodotte da noi: così in un circolo vizioso i rifugiati finanziano i gruppi armati, che comprano le armi per fare le guerre che “producono” altri migranti).
L’ideologia della paura attecchisce meno in Islanda, forse perché non hanno interessi nella guerra, forse perché culturalmente hanno un’identità più solida della nostra, che oscilla secondo i periodi di benessere o crisi, passando da un individualismo menefreghista a un patriottismo artificioso sempre a rischio di sfociare in nazionalismo cialtrone, come purtroppo la nostra storia ci ha mostrato.
Bisogna essere forti e sicuri di sé per essere generosi, e noi evidentemente non lo siamo.