Marisa Merz: una maestra del nostro tempo
 Se n’è andata lo scorso luglio, all’età di 93 anni, Marisa Merz (Torino 1926-2019) straordinaria figura dell’arte italiana, un’artista dal linguaggio inconfondibile ma che ha mantenuto una posizione sempre schiva nei confronti del sistema (maschile) dell’arte: “A me non interessa né il potere né la carriera …. Mi batto contro la malizia e la competizione” affermava, infatti, Marisa. E’ forse per questo che anche per lei, come per molte artiste della sua generazione, la piena consacrazione è avvenuta tardivamente (nonostante la partecipazione fin dai primi anni ‘80 alle più prestigiose rassegne del contemporaneo), soprattutto negli ultimi decenni, grazie a significative personali e riconoscimenti fino al Leone d’oro alla carriera (Biennale di Venezia del 2013) e alla grande retrospettiva al Met di New York del 2017.
Se n’è andata lo scorso luglio, all’età di 93 anni, Marisa Merz (Torino 1926-2019) straordinaria figura dell’arte italiana, un’artista dal linguaggio inconfondibile ma che ha mantenuto una posizione sempre schiva nei confronti del sistema (maschile) dell’arte: “A me non interessa né il potere né la carriera …. Mi batto contro la malizia e la competizione” affermava, infatti, Marisa. E’ forse per questo che anche per lei, come per molte artiste della sua generazione, la piena consacrazione è avvenuta tardivamente (nonostante la partecipazione fin dai primi anni ‘80 alle più prestigiose rassegne del contemporaneo), soprattutto negli ultimi decenni, grazie a significative personali e riconoscimenti fino al Leone d’oro alla carriera (Biennale di Venezia del 2013) e alla grande retrospettiva al Met di New York del 2017.
La sua ricerca innovativa e personale, che in mezzo secolo ha toccato una vasta gamma di medium, si è sviluppata a partire dagli anni ’60 nell’ambito dell’Arte Povera, il movimento del quale fu la sola interprete femminile, accanto al suo compagno di tutta la vita, Mario Merz. La sua presenza, oscurata, allora, dai suoi più noti compagni di strada fornì tuttavia al movimento un contributo essenziale, come ha riconosciuto Piero Gilardi, come lei legato all’Arte povera, indicando nel lavoro di Marisa la più coerente manifestazione di quella stretta corrispondenza fra espressione artistica e vita personale cui proprio i poveristi miravano.
 E’ stata questa, infatti, una caratteristica centrale dell’arte di Marisa Merz che così dichiarava fin dagli inizi: “Non vi è mai stata una divisione tra la mia vita e il mio lavoro”. Non a caso la prima esposizione avvenne nella sua casa-studio di Torino, con le Sculture viventi (1966), i primi grandi lavori in lamine di alluminio, sottili strisce lucenti che definiscono forme a spirale, irregolari e mobili, corpi curvilinei avviluppati e sospesi al soffitto, che richiamano l’idea della crescita, della trasformazione. E in quegli anni, altre opere si presentavano quasi come estensioni del suo stesso corpo, come le famose Scarpette (1968) che, diceva Marisa, “come altri lavori … corrispondono alle mie misure, alle mie possibilità.” Siamo qui di fronte alle prime opere in filo di nylon o rame lavorato a maglia che costituiranno una costante del suo operare e che l’artista costruiva piegando, contraddittoriamente, materiali rigidi attraverso il gesto “povero”, tipico dell’operare delle donne e destinato a materiali cedevoli. Marisa compiva così un doppio movimento: liberava il gesto dell’intrecciare dallo stereotipo della “domesticità”, mettendo in discussione i confini fra arte e artigianato, e immetteva
E’ stata questa, infatti, una caratteristica centrale dell’arte di Marisa Merz che così dichiarava fin dagli inizi: “Non vi è mai stata una divisione tra la mia vita e il mio lavoro”. Non a caso la prima esposizione avvenne nella sua casa-studio di Torino, con le Sculture viventi (1966), i primi grandi lavori in lamine di alluminio, sottili strisce lucenti che definiscono forme a spirale, irregolari e mobili, corpi curvilinei avviluppati e sospesi al soffitto, che richiamano l’idea della crescita, della trasformazione. E in quegli anni, altre opere si presentavano quasi come estensioni del suo stesso corpo, come le famose Scarpette (1968) che, diceva Marisa, “come altri lavori … corrispondono alle mie misure, alle mie possibilità.” Siamo qui di fronte alle prime opere in filo di nylon o rame lavorato a maglia che costituiranno una costante del suo operare e che l’artista costruiva piegando, contraddittoriamente, materiali rigidi attraverso il gesto “povero”, tipico dell’operare delle donne e destinato a materiali cedevoli. Marisa compiva così un doppio movimento: liberava il gesto dell’intrecciare dallo stereotipo della “domesticità”, mettendo in discussione i confini fra arte e artigianato, e immetteva  un’attività che parlava della tradizione e dell’esperienza femminile nel cuore vivo della pratica estetica, secondo un approccio condiviso in quel momento, seppure in forme e modi diversi, da tante altre artiste -italiane e non-.
un’attività che parlava della tradizione e dell’esperienza femminile nel cuore vivo della pratica estetica, secondo un approccio condiviso in quel momento, seppure in forme e modi diversi, da tante altre artiste -italiane e non-.
Ma si trattava soprattutto di un modo di creare completamente altro rispetto a quello dei suoi compagni di movimento, un modo che partiva dal corpo, dalla dimensione domestica, dall’essere madre (molte sono le opere legate all’infanzia della figlia Beatrice) ma andando oltre qualsiasi stereotipo: “… l’artista è già un ruolo stabilito come la moglie, il figlio. Ma io non ci sto mica in questi ruoli, ruoli separatori, elenchi …”. Così sentiva Marisa.
Ancorato all’”eterno” gesto femminile di sferruzzare, allora, anche il tempo assumeva per lei un’altra evidenza, indugiando in una sospensione prima e oltre la storia: non a caso, era solita esporre le sue opere senza data e senza titolo, ponendo un’attenzione particolare alla loro presentazione e collocazione spaziale.
Nella sua lunga esperienza artistica, l’artista ha notevolmente arricchito il proprio repertorio di forme e diversificato tecniche e materie: testine in terra cruda, dipinti, opere di carta e disegni a matita, violini in cera a volte “silenziosi”, a volte con un filo d’acqua che restituiva loro la voce. La componente spazio-temporale è invece rimasta sempre centrale nell’organizzazione delle installazioni-ambiente, realizzate riunendo, combinando e ridefinendo i lavori in modi ogni volta diversi, attraverso percorsi inediti e dando origine a nuovi significati e relazioni di senso tra le opere e fra queste e lo spazio che le ospita, uno spazio espositivo che si mostrava sempre più come spazio intimo, affettivo dell’artista.
Con gli anni settanta ha inizio la serie delle Teste, piccole sculture in argilla cruda, in cera o in gesso, appena abbozzate, a volte completate da stesure di colore o colate di cera o impreziosite da raffin ati inserti cromatici in lamina d’oro. Generalmente esposte su treppiedi sono lievi, eteree, nel tempo sempre più incorporee; rivolgono lo sguardo verso l’alto, in alcune gli occhi sono chiusi, occhi che guardano dentro di sé. In continuità con le teste sono i volti femminili che l’artista inizia a disegnare e poi a dipingere a partire degli anni ‘80: visi dai lineamenti stilizzati che affiorano da carta o legni, segni di una dimensione umana che rimanda alla questione dell’essere e che sfugge -e sfida- ogni espressione identitaria.
ati inserti cromatici in lamina d’oro. Generalmente esposte su treppiedi sono lievi, eteree, nel tempo sempre più incorporee; rivolgono lo sguardo verso l’alto, in alcune gli occhi sono chiusi, occhi che guardano dentro di sé. In continuità con le teste sono i volti femminili che l’artista inizia a disegnare e poi a dipingere a partire degli anni ‘80: visi dai lineamenti stilizzati che affiorano da carta o legni, segni di una dimensione umana che rimanda alla questione dell’essere e che sfugge -e sfida- ogni espressione identitaria.
Il disegno, al di là dai diversi materiali utilizzati, è elemento di connessione tra le diverse forme espressive: un tratto veloce e aggrovigliato, linee ripetute e vorticose straordinariamente leggere che determinano una sensazione di non-finitezza dell’immagine che non appare mai del tutto risolta o terminata. A partire dagli anni ’90, l’indeterminatezza si associa alla precarietà: l’artista inizia ad organizzare i propri lavori disponendo dipinti o disegni dentro scatole di legno con una lastra di vetro appena appoggiata contro, il tutto disposto su banali piani di legno o scaffalature metalliche o appoggiato al pavimento. E’ ovvio che l’opera è la risultante dell’insieme ma gioca sulla contraddizione, nel richiamare il “quadro” che non è, nel mostrare la possibilità di una sempre diversa combinazione delle componenti, sfuggendo a ogni fissa determinazione, in una “stabile” provvisorietà e precarietà.
I lavori più recenti sono delicate figure femminili sempre più spirituali ed eteree, segni rarefatti di linee e colori delicati in cui domina un blu simbolico, spesso in composizioni complesse che costituiscono quasi una summa della sua intera produzione espressa nel libero gioco tra materia e forma, nella continuità tra opera ed esperienza.



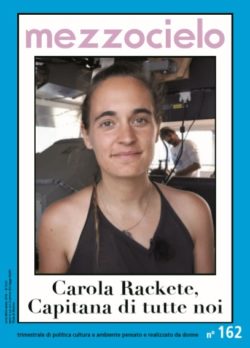




Benvenuta nel sito di Mezzocielo e tantissimi complimenti per l’articolo splendido su Marisa Merz!